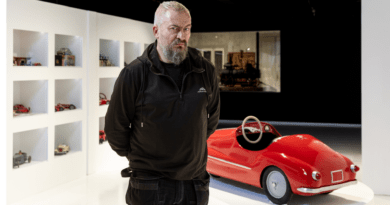Ciclisti fuori dalle corsie di bus e tram, la svolta del Codice
La riforma del Codice della Strada italiano, entrata in vigore nel 2024 e consolidata nel 2025, ha introdotto un divieto significativo: i ciclisti non possono più accedere alle corsie riservate a tram e autobus, salvo rare eccezioni autorizzate localmente. Questa misura segna una svolta rispetto al passato, quando molte città consentivano la condivisione di tali corsie per incentivare la mobilità sostenibile. L’obiettivo principale è migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del trasporto pubblico, riducendo i rischi per i ciclisti in spazi condivisi con mezzi pesanti.
Sicurezza al centro
Prima della riforma, i Comuni potevano autorizzare i ciclisti a usare le corsie preferenziali, ma i dati Istat del 2023 hanno evidenziato la pericolosità di questa pratica: il 15% degli incidenti urbani che coinvolgevano ciclisti avveniva in corsie condivise.
Nel 2024, la percentuale è diminuita, ma il rischio resta significativo, giustificando il divieto. La norma mira a separare i flussi di traffico, relegando i ciclisti alle piste ciclabili o alla carreggiata ordinaria, proteggendoli dalla vulnerabilità accanto a tram e bus, poco maneggevoli in spazi ristretti.
Reazioni e prospettive
La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) ha accolto il divieto con prudenza, sottolineando però l’urgenza di investire in piste ciclabili dedicate.
Senza infrastrutture adeguate, i ciclisti potrebbero finire su strade ancora più pericolose.
Paesi come Olanda e Danimarca, con corsie separate e tecnologie avanzate, dimostrano che è possibile ridurre gli incidenti.
In Italia, città come Milano e Bologna stanno sperimentando soluzioni simili, ma la loro diffusione è limitata.
Sanzioni e responsabilità
Trasgredire il divieto comporta multe da 83 a 332 euro, con possibili maggiorazioni per recidiva. In caso di incidente, il ciclista potrebbe essere ritenuto interamente responsabile, perdendo diritto a risarcimenti. Questo aspetto ha acceso dibattiti: alcuni lo considerano troppo severo, altri un deterrente necessario per il rispetto delle regole.
Infrastrutture: la chiave del cambiamento
La riforma spinge le amministrazioni a ripensare la mobilità urbana. Le corsie ciclabili promiscue restano possibili, ma richiedono investimenti significativi. Secondo Legambiente (2025), solo il 12% dei capoluoghi italiani ha una rete ciclabile sicura e continua. Il PNRR ha stanziato 600 milioni di euro per la mobilità sostenibile, ma la frammentazione dei fondi rallenta i progressi. Serve una visione integrata per collegare periferie e centri con reti ciclabili efficienti e segnaletica chiara.
Uniformità normativa
Prima del 2024, la frammentazione delle regole creava confusione: alcune città permettevano l’accesso alle corsie preferenziali, altre lo vietavano. La riforma stabilisce un criterio unico nazionale, chiarendo che le corsie riservate sono off-limits senza autorizzazioni. L’articolo 182 del Codice della Strada obbliga i ciclisti a usare le piste ciclabili, dove presenti, eliminando ambiguità.
Segnaletica e consapevolezza
La leggibilità dei segnali stradali è cruciale, poiché molti ciclisti si orientano con questi. Le corsie devono indicare chiaramente il divieto per evitare errori o contestazioni. Città come Torino hanno introdotto pannelli luminosi e segnaletica dinamica nel 2025, ma queste innovazioni non sono ancora standard.
Verso un futuro sostenibile
La norma riflette una tendenza globale a separare i flussi di traffico per ridurre i rischi.
Tuttavia, il suo successo dipende dalla capacità di colmare il gap infrastrutturale.
Esempi europei come Copenaghen dimostrano che reti ciclabili efficienti possono coesistere con un trasporto pubblico capillare.
Per i ciclisti, conoscere le regole, verificare la segnaletica e rispettare i divieti è essenziale. La sfida è trasformare questa riforma in un’opportunità per città più vivibili, dove la bicicletta diventi simbolo di sostenibilità e benessere.